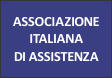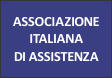|
5
febbraio
2016
-
Incontro Don Luigi Ciotti, fondatore di
Libera (Associazioni, nomi e numeri contro
le mafie), in una mattinata di fine gennaio
a Città del Messico. L’appuntamento è nella
sede di Cauce Ciudadano (Alveo
Cittadino), associazione partner di Libera
che lavora coi giovani dei quartieri
marginali. È uno dei pochi momenti
disponibili nell’agenda di Don Ciotti che ha
in programma una lunga serie di incontri con
organizzazioni della società civile e
vittime della criminalità nel quadro
dell’iniziativa “Messico per la Pace”.
Questa campagna ha l’obiettivo di far
conoscere in Italia la difficile situazione
messicana e sostenere le realtà che in loco
lottano per la sua trasformazione.
Qual è l’importanza del Messico per Libera?
Sono venuto tante volte in Messico. Proprio
in questi giorni degli amici mi hanno
consegnato dei libri che abbiamo co-editato
insieme sul tema della droga. Come Gruppo
Abele avevamo portato anche il tema delle
dipendenze dalle droghe con dei contatti in
Messico per fare progetti insieme,
condividere esperienze e darci una mano
reciprocamente. Credo che si debbano
condividere le esperienze che si fanno e poi
ognuno deve calarle nel proprio contesto e
territori, nella propria cultura e nel
percorso della gente. Questo ha permesso di
conoscerci: dire droga vuol dire anche
mafia. Il traffico delle sostanze
stupefacenti è in mano nella sua quasi
totalità alle organizzazioni criminali e
specialmente a quelle criminali mafiose.
Quindi, come in Italia, Libera nasce un po’
dalla storia del Gruppo Abele, che era
impegnato contro la varie forme di
dipendenza e non solo. Anche le forme di
sfruttamento, prostituzione, la tratta, la
corruzione o l’illegalità. E’ stato più
facile qui sentire il bisogno di creare una
collaborazione. E così è nata, perché il
problema del narcotraffico è un problema che
ci tocca tutti, no? Sono stato anche in
altre nazioni dell’America Latina proprio
per questa ragione. Ecco che questo rapporto
nasce perché ci uniscono gli stessi
interessi e le stesse problematiche, pur se
in regioni e contesti diverse. Il
narcotraffico ha dimensioni criminali non
indifferenti. Perché penso alle oltre 26mila
persone scomparse, penso che la prima causa
di morte nel mondo giovanile qui è
l’omicidio, mentre in altri paesi sono gli
incidenti stradali in quella fascia d’età.
Penso alle oltre 180mila vittime accertate
della guerra di mafia in questo territorio,
quindi sono numeri grandi, però, con numeri
molto più piccoli, abbiamo vissuto parte di
questa storia anche nel nostro paese perché
quanti morti ha fatto e continua a fare
anche in Italia, pur con numeri
completamente diversi, la violenza
criminale?
Cosa possono avere in comune le esperienze
dell’Italia e del Messico? Cosa può
apportare Libera dall’Italia al Messico?
E’ uno scambio che ci arricchisce
reciprocamente. Ogni volta che vengo qui
imparo. Conosco esperienze, coraggio,
creatività, fantasia. E il lavoro nelle
periferie, dentro i barrios e i
territori difficili. Ho toccato con mano il
coraggio di reagire da parte di molti,
cresciuti dentro queste organizzazioni
magari sin da piccoli, che poi si fanno
promotori di un percorso alternativo per
uscire da questi circuiti criminali. Carlos
Cruz dell’associazione Cauce Ciudadano
è una di queste storie. Quindi c’è una
reciprocità perché ci si arricchisce e
ognuno è chiamato a dare il proprio apporto
e contributo senza calarlo dall’alto. E
questo avviene in tutti i territori. Qui
stiamo costruendo insieme dei percorsi: ALAS,
la rete di Libera in America Latina, parte
dalla stima, dall’attenzione, dalla
riconoscenza, dal rispetto e dalla
valorizzazione per cui proviamo gratitudine
per le realtà che qui sono impegnate. E allo
stesso modo abbiamo fatto in modo che
l’esperienza maturata nel nostro paese
potesse diventare un punto di riferimento.
Credo che sia in Italia che qui abbiamo
colto questo grande bisogno che c’è: io lo
chiamo grido di libertà. In che senso
libertà? Chi è povero non è libero, chi è
schiacciato dalla violenza criminale non lo
è, chi è ricattato non è libero, le ragazze
sfruttate non sono libere. E’ quindi questo
grido di libertà che ci unisce, pur in
contesti diversi. Oltre che il più prezioso
dei beni la libertà è la più esigente delle
responsabilità. Abbiamo la responsabilità di
impegnare un po’ della nostra libertà per
aiutare chi libero non è. Abbiamo deciso di
farlo mettendo insieme tante associazioni e
realtà di mondi e contesti completamente
diversi perché troverai movimenti cattolici
e più laici, giovani e anziani, eccetera.
In che modo?
Attraverso tre strumenti molto importanti
che cerchiamo di condividere. Primo, quello
culturale. Perché la cultura risveglia le
coscienze, il lavoro nelle scuole, con le
università. Abbiamo appena fatto qui con
Cauce Ciudadano un in incontro e s’è
lavorato sui linguaggi che devono tenere
conto della ricchezza dei contenuti e devono
essere accessibili. Non dimentichiamo che
l’unità di misura dei rapporti umani è la
relazione e questa ha bisogno di un
linguaggio che sia accessibile a tutte le
persone in forme e livelli diversi. Abbiamo
condiviso questa esigenza.
La seconda cosa che ci unisce è la memoria
che deve trasformarsi in impegno per non
diventare celebrazione, evento. Spesso c’è
questo grosso rischio, ma la memoria io l’ho
sempre inquadrata con un’espressione:
trasformare la memoria in un’etica
dell’impegno. Ecco in Italia abbiam cercato
di fare questo, di non lasciar soli i
familiari, di tutelarli ma anche di fare una
battaglia politica affinché abbiano una
serie di garanzie. Devo dire che le vittime
innocenti accertate della criminalità
mafiosa hanno già dei riconoscimenti nel
nostro paese ma non per tutti. Ad esempio
quelli che son stati uccisi prima del 1961
non sono riconosciuti e non capisco perché…
Pare sia sempre l’economia che determina
l’attenzione che, invece, dovrebbe
rivolgersi maggiormente alla storia delle
persone. Abbiamo cercato di stanarli, di
essergli vicini, di sentire la
responsabilità della memoria, il dovere di
trasmettere una memoria, ma soprattutto di
creare le condizioni per cui nessuno si
dimentichi che il miglior modo di fare
memoria è quello d’impegnarci veramente di
più tutti. Non solo un giorno all’anno.
Abbiamo scelto il primo giorno di primavera
per ricordare tutte le vittime. Il 21 di
marzo ogni anno in una città. Quest’anno
sarà fatto in tutta Italia alla stessa ora
dello stesso giorno la lettura di questa
lista interminabile di nomi: è un segnale
evidentemente però guai se ci dimentichiamo
che la memoria va bene ma per essere vera
deve essere un impegno. Abbiamo dato una
mano a molti familiari a trasformare il loro
dolore, la loro sofferenza e fatica in
impegno e testimonianza. A non rinchiudersi
nel loro dolore, nelle loro paure e
nell’ansia, ma a trovare punti di
riferimento per diventare anche loro una
forza. Non una categoria, come si dice “voi
siete i familiari”, ma cittadini che si
assumono responsabilità e tocca a noi non
lasciarli soli.
Il terzo punto è stato quello che ci ha
creato più problemi anche se adesso tutti
capiscono l’importanza della confisca dei
beni ai mafiosi. Quando è nata Libera
abbiamo condiviso il sogno di Pio Latorre.
Siciliano, deputato e sindacalista, aveva
intuito che bisognava inserire nel codice
penale i reati di stampo mafioso. Poi la
legge venne fatta, ma lui non la vide perché
fu ucciso prima. L’altra sua grande
intuizione è stata quella per cui bisogna
sottrarre ai mafiosi i patrimoni perché
cos’è che più disturba i mafiosi e i grandi
boss? Il loro obiettivo è il potere, il
denaro, la forza e allora li disturba il
fatto che tu gli togli questo potere e la
loro immagine, oltre a quei patrimoni che ha
realizzato spesso con la morte, il sangue e
la violenza. Latorre l’aveva intuito ed è
stato ammazzato quattro mesi prima di vedere
approvata la legge. Quando nasce Libera
pensiamo che il suo sogno deve realizzarsi.
La legge che era passata non era completa,
non prevedeva adeguatamente l’aspetto della
confisca dei beni. E per questo abbiamo
raccolto un milione di firme per stimolare i
cittadini a prendere posizione, a unire le
forze per chiedere al parlamento e alla
politica del nostro paese una legge per la
confisca dei beni dei mafiosi. Per
migliorarla s’è aggiunto anche l’uso sociale
di quei beni quando possibile. E oggi sono
centinaia le realtà che hanno accesso a
questo attraverso bandi pubblici. Abbiamo
aperto un po’ questa strada facendo le prime
cooperative su terreni agricoli però con la
creazione dei consorzi dei comuni. I beni
confiscati restano dello Stato che li affida
ai comuni. Questi secondo la legge possono
destinarli ad usi per il bene comune o anche
dare loro un uso sociale in favore delle
cooperative o associazioni. Lo Stato non dà
i soldi alle cooperative ma al consorzio dei
comuni, essendo loro i gestori. Abbiamo
cercato di creare cooperative di tipo
agricolo sui beni confiscati col progetto
Libera Terra e la scelta del biologico.
Questo vuol dire dare lavoro. Era difficile
fino a 20 anni fa immaginare nel nostro
paese che le ricchezze delle mafie potessero
trasformarsi in opportunità di lavoro, in
luoghi di stimolo alla partecipazione civile
e in strumenti di cambiamento.
Dicevi ieri presso l’Istituto Italiano di
Cultura che corruzione e mafia sono due
facce della stessa medaglia. Sarebbe
applicabile una politica di questo tipo
anche in Messico, malgrado suoi alti livelli
di violenza e la connivenza degli apparati
di stato con la criminalità?
Direi di sì. Qui, ma anche nel nostro paese,
i livelli di corruzione sono eccezionali.
Allora vorrei dire che l’economia mafiosa
oggi è per molti versi legata all’economia
legale, al sistema che governa il libero
mercato. La finanza, gli scambi e la
corruzione chiamano in causa l’etica privata
e pubblica. Allora in questo senso la lotta
alle mafie e alla corruzione non sono solo
un dovere etico ma anche una priorità
economica perché ci impoverisce tutti. E’
questo il forte potere in mano ai mafiosi.
Il problema non sono quindi solo i poteri
legali, né solo quelli mafiosi il cui scopo
è il denaro, la forza e fare soldi, in
sostanza. Il vero problema sono anche i
poteri legali che si muovono illegalmente.
Le mafie sono dei parassiti di un sistema
che distrugge il lavoro, la dignità e la
speranza. Per raggiungere il loro obiettivo
s’avvalgono di questo o quel potere che gli
permette di sopravvivere e le protegge. E
sono segmenti del potere politico. Più che
mai oggi sono anche i poteri economici,
imprenditoriali e finanziari. Questo è
chiaro, tant’è vero che testualmente la
Banca d’Italia anni addietro parlò di
“corrotti che siedono regolarmente nei
consigli d’amministrazione di enti
pubblici”. Allora dico, insomma, siccome lo
denunciate seriamente, si crei rapidamente
un sistema per farli venir fuori, per
cacciarli. Magari dei passi si stanno
facendo, ma credo che resti fondamentale il
problema della corruzione che è
l’incubatrice del potere mafioso. Ma c’è di
più. L’altro elemento da affrontare è la
mafiosità diffusa.

19 gennaio 2016. Paolo Pagliai e Don Luigi Ciotti
all'Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico.
E’ un concetto simile a quello “messicano”
di narcocultura?
Esatto. E’ il vero patrimonio delle mafie
prima ancora di quello economico. I mafiosi
riescono a fare questo perché c’è proprio
una mentalità mafiosa che ci circonda. La
vediamo nel nostro paese, anche se certe
cose sono cambiate. Noi e altri abbiamo
lavorato molto nelle scuole, nelle
università, con la magistratura e condotto
una battaglia culturale. Dei passi in avanti
sono stati fatti e credo che abbiamo una tra
le migliori leggi per il contrasto alle
mafie. Certo poi bisogna anche tradurla in
pratica. Quello che manca ad esempio in un
paese come il Messico è una commissione
antimafia, la politica deve attrezzarsi. E’
uno strumento politico fondamentale. Il
nostro ruolo è un altro, riguarda la società
civile, l’educazione, la dimensione
culturale, l’impegno sociale perché abbiamo
troppi cittadini a intermittenza in giro, a
seconda delle emozioni e dei momenti, e
abbiamo bisogno di cittadini più
responsabili.
Anche qui c’è la percezione che i movimenti
di protesta come quello per la Pace del 2011
e quello nato intorno ai genitori dei 43
desaparecidos de Ayotzinapa abbiano
funzionato come ondate che poi rientrano e
non sempre si concretizzano in cambiamenti.
E’ vero. Dico sempre che la strada per tutti
è in salita. Ma tre parole per me diventano
fondamentali. La continuità nel fare le
cose, anche se è dura e difficile. La
seconda parola è la condivisione, non è
opera di navigatori solitari. Credo
nell’unione di energie e pensieri. Ecco
allora la nostra esperienza mi ha portato
qui 5 anni fa, chiamato dalla conferenza
episcopale messicana a parlare a tutti i
vescovi perché l’esempio che s’era costruito
un po’ in Italia interessava a questo
episcopato. Si chiedevano come è stato
possibile mettere insieme tanti movimenti e
realtà così diverse tra di loro. E’ stata
una scommessa evidentemente. Credo che in
ogni nazione, pur con caratteristiche
diverse e anche se per esempio qui il ceto
medio è più ridotto ed è una terra di
estremi, la strada del “Noi”, di unire forze
ed energie con corresponsabilità diventi
importante. Allora c’è la continuità, la
condivisione, il noi, e la
corresponsabilità. Corresponsabilità vuol
dire che noi sentiamo che dobbiamo cercare
di collaborare con le istituzioni quando
fanno la loro parte, ma di essere anche una
spina nel fianco quando non vengono
affermati i diritti, l’uguaglianza e la
dignità delle persone.
Nel contesto messicano, ma anche in certa
misura in quello italiano, c’è da
considerare che attivisti, giornalisti,
difensori dei diritti umani e tutte le
categorie che rappresentano comunità o
gruppi sociali sono tra due fuochi: la
criminalità organizzata e apparati dello
stato a vari livelli che remano contro di
loro. A volte questo avviene mediante
legislazioni che penalizzano o
criminalizzano le proteste e le domande
sociali. Spesso queste vengono interpretate
dai media e da un’opinione pubblica
piuttosto conservatrice come
“delinquenziali” e paragonate alla
criminalità organizzata. Che ne pensi?
Sono molto consapevole di questo, di questi
elementi, perché a forza di venire qui e
ascoltare vedo che da una parte c’è questa
situazione ma dall’altra anche il coraggio.
E ce ne vuole veramente tanto, la dignità,
il non venire meno. Ho visto gruppi di
ragazzi, le associazioni l’altro giorno a
Cuernavaca, e abbiamo fatto un incontro di
grande valore. Questa è una grande battaglia
politica che va portata avanti, affidata
però al popolo, alla nazione, per quella che
è la sua parte. Mi fa piacere che ci siano
anche delle collaborazioni con la
magistratura italiana, alcuni sono venuti
qui, ma è da anni che ci sono collaborazioni
per cercare dei sistemi. Bisogna fare in
modo che non diventino solo di facciata e
che si concretizzino perché questa è la
strada. La corruzione, che si trova a
diversi livelli, ci impoverisce tutti e,
devo dire che è così anche da noi: il fango,
le manovre, il destabilizzare. Dobbiamo
avere più coraggio tutti. Credo anche che la
prima grande riforma da fare, guardando più
all’Europa evidentemente, sia un’autoriforma
delle nostre coscienze, di risveglio delle
nostre coscienze. Certo qui c’è una parte
della popolazione che culturalmente fa più
fatica o ha meno strumenti, ma anche da noi
in Italia ora ci sono 8 milioni di persone
in povertà relativa e 4 in povertà assoluta.
Siamo agli ultimi posti in Europa,
nonostante i miglioramenti negli ultimi
tempi, per la dispersione scolastica.
Milioni di italiani sono analfabeti o hanno
forme di analfabetismo di ritorno. E allora,
lotta alle mafie…
Come vedi un contesto come il messicano in
cui c’è sempre manovalanza criminale
disponibile per via della povertà e la
mancanza di opportunità?
Sì è vero, ma anche da noi adesso tutti i
vuoti creati, per il grande lavoro degli
arresti dei latitanti, vengono subito
riempiti da nuove leve: la mancanza di
lavoro, e molti che si perdono per strada
nella scuola, favorisce tutto questo. Dico
sempre che le mafie non sono figlie della
povertà e dell’arretratezza, ma è indubbio
che povertà, disuguaglianze e marginalità
sono i serbatoi che favoriscono la loro
espansione per cui bisogna affrontare il
problema delle pratiche sociali vere, reali.
Lotta alla mafia nel nostro paese vuol dire
lavoro, cultura, scuola. Certo, anche il
lavoro dei magistrati e delle forze
dell’ordine, ma c’è anche una risposta di
politiche sociali che diventa importante. Va
chiarito che la mafia non è figlia della
povertà, ma quelle disuguaglianze la
favoriscono moltissimo. Perché poi i grandi
capi o per esempio il capo di Cosa Nostra a
Corleone era un medico, cioè non si tratta
solo di povera gente che reagisce in un
certo modo. Oggi dietro c’è la grande
finanza, quella sporca in giro per il mondo,
quell’economia che Papa Francesco ha
chiamato “economia assassina”.
C’è dunque una responsabilità dei poteri
pubblici in un tipo di politica economica e
nella perdita di interi territori che in
Messico è molto forte?
Ma certo, è quello che dicevo prima. Le
mafie sono forti quando la politica è
debole, quando la democrazia è pallida. Per
esempio non è possibile che in Italia
crescano l’evasione fiscale e la corruzione.
Adesso tutti fanno i codici etici e io sono
preoccupato perché il primo codice etico è
la tua coscienza. Perché non basta scrivere
e fare “un protocollo”. No, sono i tuoi
comportamenti, i tuoi linguaggi, le tue
scelte, le tue frequentazioni. Oggi l’etica
è una parola che è sulla bocca di tutti,
invece chiama in causa di più le nostre
coscienze, comportamenti, linguaggi.
Qual è la posizione di Libera o tua nel
dibattito, molto acceso in Messico, sulla
legalizzazione delle droghe?
E’ un dibattito che va avanti da sempre.
Come la pensate? Sottrarre quei mercati alle
mafie può essere una strategia utile?
Io sono perché ci si metta tutti intorno a
un tavolo, spogliandosi da pregiudizi e
moralismi, per chiederci, non dimenticando
mai la dignità delle persone che è
l’obiettivo centrale, che cosa si può fare
sulla faccia di questa Terra dove già ci
sono tantissime ipocrisie. Un’ipocrisia che
tocco con mano è quando prendo un pacchetto
di sigarette, monopolio dello Stato, con
scritto “Nuoce gravemente alla salute”.
Credo sia un’ipocrisia perché le vendi e ci
metti sopra anche l’immagine della
morte…Allora che si affronti il discorso
complessivo, con vera volontà politica di
affrontare questo nodo, si aprano gli armadi
che sono blindati a Vienna dove tanti
studiosi hanno fatto ricerche eccezionali.
Lì c’è il centro dell’Onu sulle dipendenze.
Molti ricercatori di tutto il mondo hanno
lavorato per questo organismo per capire i
meccanismi, i governi, i traffici. Sono
sotto giuramento. Molti che abbiamo
incontrato, anche italiani molti bravi, ci
dicono di fare qualcosa da anni perché,
dicono, “quei documenti negli armadi, le
molte ricerche per cui abbiamo lavorato anni
e abbiamo dimostrato cosa stava dietro a
tutto questo mondo e al giro delle droghe,
non sono poi resi pubblici”. Perché quando
toccano i governi…I governi hanno diritto di
voto e quindi se il rapporto che tu mi fai,
il lavoro che ti avevo commissionato, poi
contiene denunce, allora molti son bloccati
perché vengono fuori delle cose per cui la
politica, il governo, dice che quel rapporto
non dev’essere pubblicato. Studi sui
traffici e le coperture, su cosa si nasconde
dietro. Ecco quando dico allora, per
piacere, facciamo una riflessione seria a
carte scoperte su qual è la soluzione perché
sono falliti tutti gli altri tipi di
percorso. La lotta alla droga l’abbiamo
persa tutti.
Cosa pensi della strategia di mano dura e
militarizzazione dei territori partita a
fine 2006 con la cosiddetta “guerra alle
droghe” in Messico?
Mi pare che la droga continui a essere alla
grande in giro per tutta questa Terra. Io
non ho le competenze, la professionalità,
opero nel sociale, ma vedo la disperazione
della gente. Vedo che le politiche, anche
nel nostro paese, nel nome della crisi
economica si sono fortemente ridotte, la
prevenzione è stata stroncata del 50%.
Sempre perché è il dato economico quello che
penalizza tutto. Dipende come investi poi i
soldi… Ma la droga continua ad esserci. Ce
n’è tanta, sempre di più. Io devo lavorare
per fare in modo che la gente non arrivi a
drogarsi, però dobbiamo anche chiederci come
fare per sconfiggere un mercato in mano a
questi criminali, ma che ha anche delle
coperture. E’ per questo che gli armadi di
Vienna devono aprirsi.
Ma in questo senso c’è un doppio ostacolo
alla legalizzazione: una falsa morale
nell’opinione pubblica e poi lo scoglio
politico.
Non ti so dire se è bene, se è male,
eccetera. Dico solo che bisogna trovare
veramente la volontà, liberi. La riflessione
deve essere fatta, sempre a partire dalla
dignità della persona, ma che venga fatta su
tutte le forme di dipendenza perché ci si
accanisce in una direzione e si dimenticano
le altre dipendenze. E’ una riflessione
molto seria partendo per esempio dal gioco
d’azzardo. Gruppo Abele pubblicò un libro
denunciando queste forme di dipendenze e ci
risero in faccia, mentre adesso tutti ne
parlano. Anoressia e bulimia: chi l’avrebbe
detto quando anni fa l’anticipò il Gruppo
Abele. E’ un’altra sofferenza, un’altra
forma di dipendenza, oltre al fumo, l’alcol.
Abbiamo bisogno di una grande riflessione e
non solo leggere in una direzione. Ci vuole
che la politica affronti realmente questo
problema. Io non ho la formuletta in tasca,
credo che, però, la “lotta alla droga”
l’abbiamo veramente persa tutti nell’arco di
questi anni. Nel nostro paese, l’Italia,
anni fa faceva notizia se un ragazzo moriva
di overdose. Adesso sono riprese le morti,
nonostante la presenza di farmaci e altro,
ma non fa più notizia. Si dà quasi per
scontato, è venuta meno quell’indignazione
vera che scuote le coscienze e ci fa mettere
in gioco.
Beh, qui il grande scossone è stato
sicuramente il crimine contro i 43 studenti
di Ayotzinapa.
Me lo ricordo bene perché mi arrivò una
lettera quando stavamo facendo Contro-Mafie
in Italia, un evento biennale cui
partecipano più di tremila persone e
lavorano in gruppi. All’assemblea conclusiva
a Roma era arrivata una lettera di alcuni
ragazzi messicani. Il loro grido dal Messico
era: “Fate qualcosa, ditelo al mondo”.
Davanti a tutte quelle persone e ai media ho
dato la denuncia. Ho letto quella lettera
perché mi hanno scritto un testo pesante e
drammatico chiedendo di non essere
abbandonati “davanti ai criminali e ai
politici mafiosi che usano polizie ed
esercito per sequestrare”. E alla fine si
sono mossi di più. Allo stesso modo non
vanno dimenticati gli altri ventiseimila.
Il problema di molti casi qui in Messico,
tra cui la “notte di Iguala” e la
persecuzione contro gli studenti di
Ayotzinapa, è che viene riscontrata
dall’inizio la partecipazione della polizia
e di organi statali a vari livelli
all’interno di operazioni complesse.
Non basta solo indignarci e commuoverci al
riguardo, dobbiamo muoverci di più tutti.
Attenzione che qui c’è un livello di
corruzione… Non devo spiegarlo io a voi. Ma
lo stesso elemento che ha visto degli
apparati dello stato coinvolti c’è anche in
Italia, c’è un processo Stato-mafia in atto
nel nostro paese che ha visto la complicità
degli uomini degli apparati dello Stato. I
mafiosi sono nessuno. Nessuno. Riescono a
realizzare i loro obiettivi perché trovano
alleanze e compromissioni con segmenti della
politica e della finanza, dell’economia.
Trovano professionisti che si mettono al
loro servizio.
Qual è secondo te il peggior nemico della
mafia?
Beh, direi che siamo noi. La grande rivolta
deve partire dal basso, è la rivolta delle
persone che dal basso sentono dentro di loro
che il cambiamento ha bisogno di ognuno di
noi. Noi dobbiamo essere un cambiamento.
Queste realtà che ho incontrato sono un
segno di speranza: visti male da molte
istituzioni e ostacolati, sono un segno che
dimostra che la strada è questa. Cittadini
più responsabili e gruppi che agiscono, però
la politica dovrebbe creare le condizioni.
Il problema messicano è che più che “creare
condizioni” si creano ostacoli alla libertà
di stampa e all’organizzazione e la protesta
popolari che di solito vengono smantellate.
La presenza di Libera e la rete ALAS, che
promuove l’antimafia sociale, serve a fare
in modo per prima cosa di non lasciarli
soli, di dare loro un respiro più
internazionale con cui arricchirsi
reciprocamente e creare visibilità.
Com’è stato il tuo incontro in Messico coi
genitori di Gisela Mota, la sindachessa di
Temixco assassinata da presunti
narcotrafficanti di fronte all’inizio di
gennaio?
Coi familiari delle vittime ci lavoro da
anni e non è un lavoro, è un incontro e ti
cambia la vita. Senti più prepotente dentro
di te il desiderio d’impegnarti, di fare
qualcosa, anche se ti senti piccolo o
fragile, perché ci sentiamo tutti piccoli e
fragili. Però la convinzione è che non
dobbiamo fermarci, dobbiamo avere più
coraggio e far emergere le cose positive che
ci sono per stimarle, valorizzarle e non
lasciare sole queste persone. E’ stato un
incontro che porterò profondamente nel
cuore. E’ uno dei tanti incontri che ho
vissuto con familiari in questi anni per il
mondo di fronte ai quali non ci sono parole.
Abbiamo parlato anche con tanti silenzi, ma
ho trovato in loro una grande dignità.
L’incontro, per la loro e la nostra
sicurezza, l’abbiamo dovuto fare in un luogo
che non fosse casa loro. Quando ci siamo
lasciati mi han detto una cosa che mi ha
molto colpito. Mi han detto: “Speriamo che
sia andato tutto bene”, ma non parlavano di
noi e della visita. Il nostro è un incontro
che proseguirà per non lasciarli soli e
perché Gisela deve vivere attraverso
l’impegno di tutti. E perché quei proiettili
che hanno ucciso questa ragazza… O sentiamo
che hanno colpito anche noi oppure diventa
una memoria di incontri molto retorici. La
loro preoccupazione era nei nostri riguardi,
speravano che non ci avessero seguiti e
visti. Loro han cercato di fare un incontro
perché temono ritorsioni. Il papà e il
fratello hanno rincorso i criminali dopo la
sparatoria contro Gisela. C’è stato poi uno
scontro con la polizia, alcuni dei
delinquenti sono morti. Quindi ci siamo
visti lontano da casa. La mamma mi ha detto
che la gente le chiede di candidarsi al
posto di sua figlia. Ne abbiamo parlato un
po’ e non so se lo farà o no. So solo che ho
ricevuto ancora una volta una lezione perché
penso a cosa vuol dire per un papà, una
mamma o un figlio vedersi uccidere le
persone care davanti agli occhi. Io lo vivo
profondamente dentro e ti senti impotente,
ma senti ancora di più la voglia di dire
“uniamo le nostre forze, con umiltà, ma
uniamo le nostre energie perché non è
possibile”.
Conosci il poeta Javier Sicilia, fondatore
del Movimento per la Pace con Giustizia e
Dignità nel 2011 che è stato per molti mesi
il riferimento del movimento delle vittime
della narcoguerra messicana?
Sì, abbiamo passato del tempo insieme. Ieri
a Cuernavaca abbiamo parlato molto, abbiamo
fatto un dibattito e un incontro bellissimo.
E’ venuto anche lui coi genitori di Gisela.
Abbiamo fatto un dibattito anche su quello
che stanno facendo loro, per me molto
arricchente. Abbiamo parlato di un po’ di
tutto perché le ferite delle persone non si
chiudono mai dentro.
Dopo l’arresto del Chapo Guzmán, capo del
cartello di Sinaloa, il presidente del
Messico ha approfittato per ribadire la
“solidità delle istituzioni” e ricordare le
varie catture di boss realizzate. Basta
questo? Cosa cambia nella guerra alle
droghe?
Ne ho parlato proprio in un’intervista con
la giornalista Carmen Aristegui alla CNN. Ho
paura di questi miti perché c’è il rischio
che tutta l’immagine e l’attenzione siano
focalizzate lì e poi ci si distragga da
altro. Preso un capo, viene subito
sostituito da altri, quindi attenzione a non
farne dei miti.
(fabrizio
lorusso / puntodincontro.mx / adattamento
DI massimo barzizza
e traduzione in spagnolo di
Fabrizio lorusso.
La presente intervista è
stata pubblicata anche su huffington
post e desinformémonos)
|