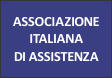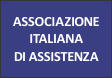|
18 luglio 2018
- Tra i tanti elementi che uniscono la
cultura italiana a quella messicana risalta,
senza dubbio, il pomodoro, ingrediente
essenziale in diverse preparazioni culinarie
di entrambi i Paesi.
La storia del suo viaggio, dalle Ande
peruviane —come pianta selvatica— fino a
giungere in Europa, è affascinante quasi
quanto i sapori e gli aromi caratteristici
dei piatti in cui viene utilizzato.
È noto che il pomodoro selvatico è
originario del Perù, l'unico sito del nostro
pianeta dove è possibile individuare una
grande varietà di specie geneticamente
diverse della pianta. Ne conosciamo tredici,
di cui due sono originarie delle isole
Galapagos e undici crescono lungo una
striscia territoriale che va dal Cile
settentrionale al sud dell'Ecuador. Due di
loro, tra cui il pomodoro che consumiamo
oggi, producono frutti rossi. Quelli di
altre due sono gialli e il resto è verde.
La pianta fu addomesticata solo dopo
l’arrivo dei semi in Mesoamerica,
trasportati dal vento, dall'acqua dei fiumi,
dal mare e dallo stomaco degli uccelli
migratori che li ingerivano. Quanto sopra è
evidente perché nelle lingue native del Perù
non esistono termini per riferirsi al
frutto, a differenza degli idiomi dei popoli
mesoamericani che lo hanno definito
chiaramente con sostantivi diversi, tra cui
il xictomatl, usato dagli Aztechi, o
tomati, comune tra i popoli del sud
del Messico e successivamente adottato dagli
spagnoli.
Uno dei primi documenti sull'uso del
pomodoro in campo culinario venne redatto da
Bernal Díaz del Castillo, conquistatore
spagnolo catturato nel 1538 in Guatemala da
alcuni nativi che, secondo il resoconto
dell’ufficiale iberico, si predisponevano a
cucinare lui e i suoi compagni in un
calderone condito con sale, peperoncino e
pomodori.

Immagine
di una versione della Historia Verdadera
de la Conquista de la Nueva España (Vera
storia della conquista della Nuova Spagna,
1568) di
Bernal
Díaz del Castillo.
Più tardi, Bernardino de Sahagún (1499-1590)
descrisse l’uso dei “pomodori grassi” negli
stufati assieme ai peperoni, semi di zucca
ed altri ingredienti venduti nei mercati
mesoamericani. Il testo del frate
francescano è il primo a distinguere tra il
xitomatl (frutto rosso di dimensioni
simili a quelle di una mela consumato oggi
in gran parte del mondo) e il tomatl,
più piccolo, verde e aspro. Entrambi fanno
parte attualmente della tradizione culinaria
messicana e sono noti rispettivamente come
jitomate e tomate.

Bernardino de
Sahagún
Sebbene la mancanza di registri precisi non
abbia permesso di determinare con certezza
né la data di arrivo in Europa del pomodoro,
né la città del Vecchio Continente a cui sia
giunto, si può ipotizzare per due motivi che
sia stato visto per la prima volta a
Siviglia, in Spagna.
Anzitutto, il frutto appare in una lista
della spesa del 1608 dell'Hospital de la Sangre e, inoltre, Siviglia era molto
frequentata da mercanti e carpentieri
italiani, fornitori di alimenti e
imbarcazioni per le spedizioni che partivano
verso il continente americano.
Sarebbero stati proprio questi commercianti
a portare nel Bel Paese una delle specie
gialle, conosciuta come Pomo d'Oro, la cui
radice era usata nel nuovo mondo per scopi
medicinali come cura per la ritenzione
urinaria.
Qualche tempo dopo, grazie a un decreto che
ordinò la coltivazione di frutta e verdura
proveniente dall'America nei pressi dei
porti spagnoli per rifornire la flotta, il
pomodoro fu portato a Tangeri, nel Marocco
settentrionale, dove per un certo periodo fu
conosciuto come “amoris del poma”, o mela
d'amore, nome con cui giunse in Francia,
dove gli furono attribuiti anche poteri
afrodisiaci.
Nei Paesi europei fuori dalla Spagna, la
pianta fu considerata tossica per lungo
tempo grazie alle osservazioni del botanico
francese Joseph Pitton de Tournefort che la
classificò erroneamente come appartenente a
una famiglia di arbusti velenosi tra i quali
si trovano la belladonna e la mandragora. In
linea con questa convinzione, in Italia
venne a lungo utilizzata solo come erba
medicinale e ornamentale, grazie anche alla
facilità con cui è possibile crearne nuovi
ceppi con frutti di colori e forme diverse.
Il primo libro di cucina che contiene
ricette che includono l'uso del pomodoro –il
volume I di “Lo scalco alla moderna”, di
Antonio Latini– fu pubblicato nel 1692 a
Napoli. Le preparazioni che utilizzavano
questo frutto come ingrediente venivano
chiamate “alla spagnuola”.
Da quel momento, l'Italia iniziò a
sperimentare con la coltivazione di diverse
varietà di pomodori a scopo culinario e a
perfezionare diversi piatti che ora
consideriamo tipici del Bel Paese.
Tra le varietà “italiane”, una delle più
conosciute è il pomodoro di San Marzano –dalla
forma più sottile e affilata di quelli di
tipo Saladette (Roma) e Bola
che si trovano generalmente in Messico–
sviluppato nei terreni vulcanici delle
pendici del Vesuvio, nella zona meridionale
della penisola. È stato definito come «il
pomodoro industriale più importante del XX
secolo» ed è l'unico che, secondo
l’Associazione Verace Pizza Napoletana, può
essere utilizzato per preparare l’autentica
pizza partenopea.

Pomodori di San Marzano.
(luca barzizza / puntodincontro)
|