
Ore 11:21 – Durante la Seconda guerra mondiale, la flotta mercantile italiana —allora tra le più importanti al mondo— venne travolta da eventi bellici, anche in Messico, con una sorte drammatica, oggi in gran parte dimenticata.
Al momento dell’entrata nel conflitto dell’Italia al fianco della Germania —il 10 giugno 1940— più di 200 navi commerciali battenti bandiera tricolore si ritrovarono impossibilitate a ritornare nel Mediterraneo, non potendo attraversare lo Stretto di Gibilterra controllato, allora come oggi, dal Regno Unito.
Tra queste vi erano molte petroliere di armatori liguri, come la Atlas Genova, che in quel periodo si trovava nel porto di Tampico, in Messico, e rimase quindi bloccata lontano dall’Europa. Sebbene ufficialmente neutrale, il Messico decise di requisire alcune navi straniere con l’obiettivo di potenziare la propria flotta petrolifera e favorire gli scambi con gli Stati Uniti, ormai prossimi all’ingresso in guerra al fianco di Francia e Regno Unito.
Fu in questo contesto che Domenico Bruzzone, originario di Genova-Pegli e capo-macchinista della petroliera, visse la sua drammatica esperienza di prigionia, riscoperta dal nipote, che porta il suo stesso nome.
«La vicenda venne alla luce grazie alle ricerche di un’immagine della nave Atlas Genova, che non era presente in nessuno dei testi ufficiali o dei documenti che descrivono queste vicende: venne ritrovata sotto forma di cartolina, presso un venditore statunitense sul sito di eBay», racconta Bruzzone.
Il destino di Domenico e degli altri marittimi italiani internati in Messico rivela, secondo il nipote, «molteplici sfaccettature della condizione umana in tempo di guerra: mentre gli Stati agiscono con logiche geopolitiche e commerciali, le persone vivono esperienze emotive ed esistenziali, segnate da relazioni, sofferenze, illusioni e speranze».
La Atlas Genova era una piro-cisterna costruita negli Stati Uniti e acquistata dall’armatore genovese Barbagelata. Seguendo l’ordine dell’ammiragliato italiano, il comandante tentò l’autoaffondamento per impedire l’uso della nave da parte messicana. «L’Atlas si adagiò su un fondale basso, e venne poi recuperata dai messicani, fu ribattezzata eLas Choapas e finì poi affondata da un sommergibile tedesco», spiega Bruzzone.
L’equipaggio venne arrestato e considerato sabotatore, e Domenico Bruzzone fu imprigionato prima a Tampico e poi alla Fortaleza de San Carlos de Perote, un’antica fortezza spagnola trasformata in un penitenziario, noto per le sue dure condizioni di isolamento, freddo e umidità.
Dopo circa due anni di prigionia, morì di polmonite nel maggio del 1942, e il suo decesso «fu comunicato alla famiglia con oltre un anno di ritardo, con il distante linguaggio burocratico di queste circostanze, accompagnato da un inventario dei suoi pochi beni personali», racconta il nipote.
Tuttavia, accanto ai freddi documenti, emergono testimonianze di grande umanità e affetto, come si può notare dalla corrispondenza tra Bruzzone e la moglie, fatta di «lettere semplici, ma delicate ed affettuose», che rivelano «un mondo emotivo fatto di rispetto e pudore, caratteristico dell’epoca e del contesto della cultura operaia in Liguria».
Un linguaggio, quello della corrispondenza privata di Bruzzone e dei suoi compagni di prigionia, «in aspro contrasto con l’aridità, burocratica e gelida, delle comunicazioni ufficiali».
Durante la prigionia a Perote, il contesto di convivenza forzata di italiani, tedeschi – e probabilmente anche alcuni giapponesi– portò alla nascita spontanea di legami di solidarietà in un ambiente ostile e isolato, fatto di privazioni e distanze.
«La vita di comunità, con i suoi rituali improvvisati e le bandiere sabaude o naziste che sembrano cadere da inconsapevoli rami, suggerisce che anche nei contesti più duri è possibile creare forme di coesione, alimentate dalla necessità di resistere e trovare senso nella condivisione e nel radicamento degli amori e degli affetti», riflette il nipote del capo-macchinista dell’Atlas Genova.
Molti di questi marittimi, una volta liberati, scelsero di rimanere in Messico, dove entrarono a far parte della comunità italiana grazie alla quale, negli anni, vennero fondate istituzioni come la Casa de Italia e la Società Dante Alighieri (il Comitato in Messico della Società Dante Alighieri era già stato fondato nel 1901, ndr), per mantenere vivi i legami con la terra d’origine.
Nel lavoro di ricostruzione di queste vicende hanno avuto un ruolo importante anche le ricerche collettive e digitali: tra queste, il blog Con la pelle appesa a un chiodo, curato da Lorenzo Colombo, che ha contribuito a far emergere numerose storie dimenticate di molte navi mercantili durante il conflitto e dei loro equipaggi.
«Alcuni discendenti di quegli uomini sono oggi figure pubbliche, professionisti e imprenditori che portano avanti la memoria dei loro padri e nonni attraverso iniziative culturali, educative e memoriali», spiega Bruzzone, che ha fatto della ricostruzione di queste vicende un progetto attivo.
«Non si tratta solo onorare un familiare», chiarisce infatti, spiegando che questa operazione di «post-memoria», come la definisce, serve anche a «denunciare l’assenza dello Stato e l’insensatezza della guerra, e riaffermare invece valori umani fondamentali come la solidarietà, l’intrapresa, l’impegno sociale».
A chiudere idealmente un cerchio, oggi, è anche il ritorno simbolico della famiglia Bruzzone in America Latina, con la fondazione dell’impresa agricola Pique Roto, in Uruguay: una scelta che trasforma la traiettoria forzata di un migrante involontario, quella del nonno, in un atto di radicamento consapevole del nipote.
«Un’impresa olivicola, con le sue radici italiane e la sua proiezione latinoamericana, è una forma di continuità, un ponte tra passato e futuro, tra luoghi e persone, tra memoria e creazione, e anche questa materializza un progetto culturale», sottolinea.
Ad approfondire ulteriormente contribuisce il volume Il viaggio inaspettato, pubblicato nel 2011 da De Ferrari Editore e scritto da Adrián Daneri Navarro (a sua volta discendente da un ufficiale ligure prigioniero in Messico), Ana Isabel González Ramella e Giacomo Daneri Hernández.
Il libro, frutto di anni di ricerche su oltre 1500 documenti e testimonianze, è stato ripubblicato in una nuova edizione promossa dalla Società Dante Alighieri di Guadalajara, presentato il 27 giugno a Genova, nell’ambito di una conferenza ospitata dalla Camera di Commercio e promossa da Casa America, con il patrocinio del Comune.
Per l’occasione, una delegazione di discendenti dei marittimi italiani internati in Messico – oggi cittadini messicani – ha raggiunto il capoluogo ligure per partecipare all’incontro, in un viaggio a ritroso che ha riannodato i fili della memoria familiare e collettiva. Un ritorno simbolico nella terra degli avi, che ha restituito volti e nomi a una pagina di storia per troppo tempo dimenticata. E che dimostra come, a ottant’anni di distanza, la memoria resta uno strumento potente per ricostruire identità e rinsaldare appartenenze.
Articolo di Lorenzo Meneghini, pubblicato il 18 giugno 2025 da ilglobo.com, piattaforma online del quotidiano Il Globo, che si rivolge alla comunità italiana all’estero.
Immagini: ilglobo.com






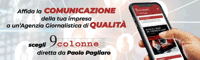




Bella questa storia e ben raccontata. Grazie.