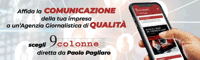Ore 10:27 – (tg24.sky.it) «Così il cuore si spezzerà, eppure spezzato vivrà», scriveva Lord Byron. Ed è con questa ferita che si apre Frankenstein di Guillermo del Toro, presentato alla Mostra di Venezia e in arrivo su Netflix dal 7 novembre. Non un semplice adattamento del romanzo di Mary Shelley, ma una liturgia gotica che è insieme confessione personale e summa del cinema del regista messicano.
Del Toro stesso lo ha detto: «È più di un sogno, è una religione». Per lui, i mostri sono santi patroni, compagni segreti di chi si sente fuori posto. E qui il mostro di sempre diventa specchio della nostra umanità, fragile e imperfetta.
Ambientato tra la guerra di Crimea e i ghiacci dell’Artico, il film segue il brillante Victor Frankenstein (Oscar Isaac), scienziato-artista con l’energia di una celebrità decaduta, ossessionato dall’idea di sfidare la morte. La sua creatura (Jacob Elordi), concepita come un mosaico di cadaveri mutilati, non nasce per suscitare orrore, ma compassione: una statua di alabastro incrinata, un Prometeo ricomposto che porta in sé la bellezza e l’orrore della vita.
Del Toro rifiuta le cuciture mostruose della tradizione: «Non volevo che fosse un cadavere mutilato. Victor non è un macellaio, voleva l’uomo perfetto». La creatura diventa bambino, filosofo, soldato risorto, figura tragica e sublime.
Il cuore pulsante del film è la relazione tra Victor e la creatura: padre e figlio, carnefice e vittima, specchi deformanti dello stesso dolore. Oscar Isaac restituisce un Victor fragile e mostruoso insieme: «un tiranno che si crede vittima», come lo definisce del Toro.
Jacob Elordi, invece, porta nella creatura l’innocenza di un neonato e la gravità di un filosofo, muovendosi con lentezza rituale, ispirata alla danza Butoh. È un corpo che impara a esistere, un cane fedele tradito, un angelo caduto. La loro fratellanza spezzata diventa metafora del trauma che attraversa generazioni, dei padri che non sanno amare e dei figli che cercano una guida.
Accanto a loro, Mia Goth è Elizabeth, creatura eterea e ultraterrena, attratta dal mondo naturale come un’entomologa di anime. È il cuore luminoso di un film immerso nell’oscurità, specchio della madre perduta di Victor e promessa mai mantenuta di amore. La sua presenza, fragile e tagliente, ricorda che nessun mostro nasce da solo: è la società a renderlo tale.
Basta guardare gli abiti verdi con tocchi di viola che sfoggia: scream queen contemporanea e sontuosa, capace di rivoluzionare l’ideale della promessa sposa. Nei suoi sguardi c’è maestà, dignità, forza, ma anche la libertà di dire che l’anima vive solo nel libero arbitrio. Come le farfalle amate da del Toro: magnifiche, ma sempre destinate alla gabbia o allo spillo, prigioniere di una collezione.
Del Toro ha dichiarato: «Il film mostra il nostro diritto all’imperfezione e ci ricorda cosa significhi restare umani nel periodo meno umanizzante della storia».
Frankenstein diventa così un manifesto politico e poetico. Non un orrore in costume, ma un melodramma rock, vibrante di rosso e nero, di corpi feriti e anime in cerca di amore. È un film che mette in scena l’ansia dell’adolescenza, la ribellione contro Dio e il capitalismo, le domande radicali che bruciano e non trovano risposta. E del Toro dissemina segni: la catena del gilet del comandante della nave danese che muta da gemma ad ancora, il dettaglio che divide.
Girato tra Toronto, Edimburgo e Glasgow, il film è una sinfonia visiva. La fotografia di Dan Laustsen alterna blu siderali e rossi sanguigni, luce artica e ombre gotiche. La scenografia di Tamara Deverell costruisce laboratori circolari, navi meccaniche oscillanti, castelli che ricordano Barry Lyndon e Crimson Peak.
Tutto è reale: set colossali, protesi, navi meccaniche. Del Toro ha rifiutato il digitale per far vibrare ogni materia di carne e ferro. Ne nasce un cinema che sembra inciso nella pietra, che restituisce al gotico la sua monumentalità.
Visionari i primi esperimenti del barone: automi che sembrano risorgere dalle macchine anatomiche di Giuseppe Salerno, spaventose composizioni di vene e ossa. È il corpo che diventa teatro, il mostro che è difforme ma non deforme, immortale eppure terrorizzato dal suo stesso destino, come Borges avrebbe chiosato.
La colonna sonora di Alexandre Desplat accompagna il film come un requiem d’amore. Archi vorticosi, organi sacri, cori solenni. Un tema che oscilla tra il lirico e il folle, capace di trasformare il dolore di Victor in musica e dare voce alla creatura. La partitura diventa un altro corpo vivo, che respira insieme ai personaggi, una preghiera che si fa eco di eternità.
Per del Toro, Frankenstein è una resa dei conti personale: un film che conclude un ciclo iniziato con Cronos e proseguito con Il labirinto del fauno e La forma dell’acqua. Un film che chiede: «Chi siamo quando siamo soli? Cosa resta quando la perfezione crolla?».
E nel confronto tra Victor e la creatura, torna la frase che chiude il film: «Nella vita il cuore umano è spezzato, ma anche con il cuore spezzato si vive».
Foto: EFE-EPA-Riccardo Antimiani e Invision-AP-Lapresse Alessandra Tarantino